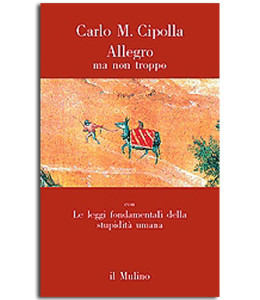 Lavorare bene fa bene a sé e agli altri.
Lavorare bene fa bene a sé e agli altri.
Carlo Maria Cipolla (1922-2000), ironico ed eclettico storico dell’economia, ha scritto qualche decennio fa un piccolo libro arguto e provocatorio che mi ha regalato fra l’altro numerosi spunti di riflessione. In Allegro ma non troppo ha affrontato con ironia lo spinoso tema della Stupidità Umana, di cui qui traccerò solamente una delle regole del comportamento da stupidi.
Cipolla afferma che: … una persona stupida è quella che causa un danno ad un’altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita. E’ questa la sua originale terza (ed aurea) Legge Fondamentale della Stupidità, la quale presuppone che gli esseri umani rientrino in una delle seguenti quattro categorie: gli sprovveduti, i banditi, gli intelligenti e, appunto, gli stupidi. I primi, da un’azione che procura un vantaggio agli altri ricevono una perdita, i banditi ottengono un risultato opposto, gli intelligenti riscuotono vantaggi per sé e per gli altri, gli stupidi… due segni negativi.
Insomma, a lavorare male nel nostro campo (in tutti i campi), cosa si ottiene? Da una parte chi opera nella salute, il medico in primis, procura un danno ai pazienti, ai familiari e alle casse smunte dello Stato, dall’altra riceve in cambio sensi di colpa (solo se è in grado di percepirli, con l’augurio che possa trarne un’esperienza costruttiva per il futuro) oppure un danno di immagine professionale o le sequele legali che possono derivare dal suo operato.
Vale la pena lavorare male?
Diceva il grande clinico Augusto Murri: … Bisognerebbe creare una Cattedra di storia degli errori in medicina. E’ mio dovere farvi assistere come medici agli errori e commentarli.
Della terapia vi parlerà il mio aiuto: lui ci crede!
Capita a volte che ad un medico vengano affidate delle storie di persone intente a sopravvivere ai bordi di questa società, affinché siano raccontate.
Diversi decenni fa, dopo la “guarigione” di una signora dai sintomi parkinsoniani indotti da un farmaco una volta che questo era stato individuato e velocemente sospeso, l’iniziale colpo di fulmine di questa vicenda a buon fine e le esperienze immediatamente successive con altri pazienti mi avevano indotto a un radicale e solido cambiamento del mio modo di procedere nella raccolta della storia clinica, una sorta di inasprimento diagnostico del mio stile di lavoro da tenente Colombo e di approccio clinico, stile che continuo ad applicare malgrado mi faccia “perdere tempo” nei tentativi ostinati di esigere che il paziente (i familiari, il medico curante) siano ordinati e precisi, come a scuola, nella documentazione clinica in possesso, nell’elenco delle malattie rilevanti e dei farmaci che vengono assunti o di cui è stato fatto uso prolungato in passato. Ovviamente, questo tempo dedicato alla raccolta minuziosa della storia delle malattie personali e familiari del paziente, del suo stile di vita, non è affatto sprecato: serve sotto il profilo tecnico ad apprendere dati importanti e spesso decisivi per formulare con tempestività un sospetto diagnostico accurato e, sotto l’aspetto umano, a creare un legame di complicità, di stima e tutela in chi si rivolge al medico per narrare la sua privata esperienza ed è felice di essere ascoltato.
Per diversi anni ho immaginato che la categoria dei medici alle soglie del duemila non avesse bisogno di informazioni sulle malattie da farmaci poiché la letteratura scientifica specifica esisteva ed era a disposizione di chi volesse aggiornarsi. Internet ha poi facilitato ogni tentativo di ricerca. Ho sbagliato previsione.
La mia benevola intuizione è stata smentita, penso, per una serie di ragioni che provo ad elencare:
- sono aumentati progressivamente i pazienti anziani, la popolazione più a rischio di eventi avversi per motivi biologici, e di conseguenza è accresciuto il numero delle persone fragili, segnate spesso dalla complessità clinica;
- in molti casi i professionisti della salute fanno fatica a gestire umanamente la fragilità, non tenendo nel debito conto che fragilità e complessità sono spesso la norma e non l’eccezione quando si affronta ogni malattia di un anziano. Ambedue i termini sono in stretto rapporto con gli aspetti clinici che ogni patologia presenta, a volte atipici e frequentemente variabili da soggetto a soggetto anche a causa della coesistenza (comorbilità) di altre patologie (polipatologia);
- esiste una progressiva difficoltà a conoscere e prevedere tutte le infinite interazioni tra organismo e farmaci, fra farmaci e cibo e fra gli stessi farmaci;
- complessità, fragilità ed eventi avversi sono con tutta evidenza dipendenti, appunto, dalla ricchezza di farmaci da assumere quotidianamente (polifarmacoterapia), l’abbondanza terapeutica che accompagna di frequente i decenni finali dell’anziano o dell’adulto fragile;
- infine, manca una solida cultura gerontologica. L’anziano è spesso considerato semplicemente un adulto. Le attenzioni dedicate al bambino non trovano un corrispettivo per l’anziano (e per l’anziana!).
Anche se oggi i miei colleghi appaiono più informati sui rischi di eventi avversi da farmaci, tuttavia non sembrano adeguatamente formati ad una solida cultura gerontologica, attenta alla diversità, alla complessità e ai bisogni dell’anziano. Per tali motivi, ancora nel 2015, i medici non sembrano capaci di cogliere i presagi malevoli che riguardano il futuro della salute dei più indifesi. Il sapere medico si è peraltro progressivamente triturato in varie specializzazioni che non comunicano tra loro: ad appesantire il bagaglio dei farmaci degli anziani concorrono a volte quegli specialisti che non sono dotati di una concezione olistica, globale, del quadro clinico (e umano) di una persona malata e fragile. Succede in varie aree della medicina in cui farmaci antivertiginosi, anti-dispepsia, anticefalea, antidepressivi, anti-dolorifici ed altri ancora, vengono aggiunti alla terapia preesistente senza curarsi delle interazioni con i farmaci preesistenti, quelli che il paziente assume da tempo, e persino degli eventi avversi specifici della nuova molecola.
Non ho ancora smesso di stupirmi ogni volta in cui mi trovo di fronte a persone segnate dalla malasanità, dalle conseguenze iatrogene (da farmaci) spesso evitabili. Confesso che a volte ho dovuto sostenere con difficoltà la collaborazione e la comunicazione con quei colleghi (certamente una minoranza, per fortuna) che non mostravano l’umiltà scientifica e la sensibilità umana necessarie per comprendere cosa fosse accaduto al nostro comune paziente in conseguenza della prescrizione di un medicinale a rischio. Mi sono scontrato con atteggiamenti di ostilità, di silenzio neanche imbarazzato, di superficialità e disinteresse o di impunita arroganza. Ho dovuto subire persino un irridente commento sul mio voler vedere tutto complesso, in occasione di un convegno, quando ho parlato di complessità evitabile mostrando delle diapositive relative a casi di demenza complessa, con alterazioni cognitive, comportamentali, parkinsonismo e disturbi vegetativi (“svenimenti”, anomalie dell’architettura del sonno, ecc.). Da neurologo entrato gradualmente nel fascino del mondo della geriatria, ho risposto a chi aveva fatto quel commento che forse, fortunatamente per lui, non aveva avuto l’occasione di incontrare tanti pazienti complicati. Avrei dovuto dire invece che “non voleva vederne” la complessità, poiché continuo a confrontarmi con una realtà in cui sono tanti gli anziani che hanno quadri clinici intricati e di difficile gestione.
Da anni mi occupo, infatti, di pazienti complessi con demenza, disturbi comportamentali seri, parkinsonismo e magari, ciliegina sulla torta, “svenimenti” ed altro ancora: sono spesso casi di demenza a corpi di Lewy o di Parkinson-parkinsonismo evoluto in demenza, già complicati per storia naturale biologica e magari ancora di più per intervento delle nostre terapie.
Gli errori, intendiamoci, si compiono anche per azioni non appropriate da parte dei familiari e dei pazienti stessi, quando magari pretendono di colmare, a tutti i costi, un vuoto di rapporti e di conoscenze con l’uso di farmaci o con gli accertamenti spesso inutili. E non sono da meno i consigli di conoscenti non esperti!
Continuo a osservare incertezze e lacune nelle pur semplici procedure diagnostiche e persino anamnestiche (lo schema “inquisitorio” delle domande obbligatorie da fare !) nel campo delle vertigini, delle perdita di coscienza di breve durata (“svenimenti”, più correttamente sincopi), delle cadute dalla dinamica incerta, degli attacchi ischemici transitori (AIT) cerebrali. In tempi recenti ho avuto modo di leggere qualche capitolo di alcuni testi per tecnici dei servizi socio-sanitari, constatando che esiste una concreta carenza sul tema degli eventi avversi da farmaci abbinata, invece, alla presenza di errori sostanziali o di omissioni nell’esposizione di alcuni argomenti rilevanti, quali sono, appunto, l’AIT e l’ictus cerebrale, terza causa di morte nel mondo occidentale e prima causa di invalidità, le perdite brevi di coscienza e l’epilessia tardiva, le cadute e i disturbi dell’equilibrio (di cui sembrano interessarsi solo i libri di geriatria) e, infine, le patologie emergenti come le demenze, il delirium e i parkinsonismi.
Su queste malattie, nella mia esperienza di neurologo dei vecchi, si abbatte troppo spesso la scure della malpratica. La neurologia è una sconosciuta.
Sono proprio i temi che ho voluto trattare più dettagliatamente, direi esclusivamente, nel mio libro Malati per forza, uscendo qualche volta dal seminato stretto degli eventi avversi neurologici da farmaci per parlare di omissione, di esami non appropriati, di eventi avversi di non specifica natura neurologica. Avevo pensato ad un manuale che potesse descrivere la fragilità dell’anziano e in fondo anche dell’adulto o addirittura del giovane reso vulnerabile dal peso di malattie, raccontando le ricadute neurologiche e generali degli errori che avvengono attraverso la superficialità della raccolta anamnestica e per l’uso non corretto di farmaci impiegati sia in campo neurologico che per patologie non neurologiche. Ho preferito parlare di storie di donne e di uomini, dei reali attori di queste spiacevoli esperienze, evitando di incasellarli in aridi schemi scientifici dove ad ogni farmaco corrisponde una reazione, le persone diventano iniziali e numeri, i casi umani ridotti a nozioni che non sempre risultano facili da accettare, capire e apprendere.
Anni fa, dopo aver parlato ad un convegno sul tema delle demenze degenerative “diverse” da quella alzheimeriana, una giovane amica e collega neurologa mi disse “bravo! si sente che tu parli dal basso!”. Devo aver assunto un’espressione stupita e forse ferita, tanto da spingere la collega a spiegarmi subito che quella frase era un complimento, che non aveva intento riduttivo e offensivo per il mio narcisismo personale e professionale: dal basso voleva dire che avevo parlato non di freddi dati statistici, ma di esseri viventi in carne ed ossa con cui mi ero impegnato, della cui storia mi ero appassionato, persone che avevo visitato, ascoltato partecipando alle loro perplessità ed al peso di una diagnosi, casi clinici e umani che mi avevano indotto a riflettere, ad appassionarmi e a studiare.
Vorrei continuare a parlare dal basso (il termine è diventato ora di moda), rivolgendomi ai colleghi medici che lavorano con umiltà, sana curiosità e passione, alle altre figure professionali essenziali per la salute nello svolgimento delle varie mansioni a contatto con i fragili in ospedale, nei diurni, nelle residenze per anziani, negli ambulatori, nelle case ad accudire i familiari bisognosi, molto spesso i nostri vecchi.
Qualche mese fa ho provato un fremito di orgoglio per una approvazione che proveniva dall’alto, da Papa Francesco, quando ha detto con la sua solita aria sincera:… chi è tentato di restare chiuso nella torre d’avorio delle conoscenze deve invece imparare ad uscire, per cogliere “l’odore delle pecore”… Un medico che non percepisce “l’odore” delle persone che a lui si affidano resta un estraneo, la cui efficacia terapeutica è limitata…
Non sono un credente ma credo in quell’uomo. E mi ha fatto capire che vado nella direzione giusta.
Mi piacerebbe allora, insieme a tutti coloro che credono di poter migliorare lo stato delle cose nella società e in campo sanitario, essere “contagioso” e suscitare interesse verso questo aspetto per nulla secondario della salute. Insieme e magari numerosi potremmo lottare per una medicina più lenta, attenta e, perché no, sorridente, che metta a proprio agio, che tenti di contrastare le attuali modalità dettate dalla frettolosità. Questa medicina della fretta che velocizza anamnesi e visita, trascura le informazioni, viene messa in atto da un drappello consistente di medici forse “strangolati dai loro camici” e dagli amministratori, medici che hanno o dovrebbero avere un compito essenziale nel campo della salute, quello di rassicurare e prendersi cura dei pazienti, concetti ben differenti dal semplice e limitato curare.
Per tanti di loro a volte le cose che non si sanno non esistono.
L’indignazione da sola non basta! Scriveva su Non arrendetevi l’anziano Stéphane Hessel, che ci ha lasciati da poco …Se qualcuno crede che per cambiare le cose basti manifestare per le strade, si sbaglia. E’ necessario che l’indignazione si trasformi in un vero impegno.
E nell’Amleto di Shakespeare è scritto: … Perdonatemi questa predica di virtù, perché nella rilassatezza di questi tempi bolsi la virtù stessa deve chiedere perdono al vizio, sì, deve inchinarsi a strisciare.
Non mi adatterò al peggio e troverò certamente compagni strada facendo!